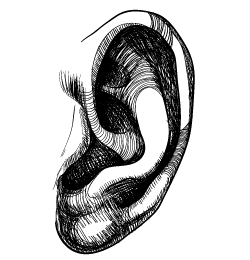
La chimica di Kurt Cobain.
«Come Amleto, insomma». Il medico lo incalzava per costringerlo a scegliere se continuare a bucarsi o tornare pulito. Era un periodo che si faceva di brutto: eroina, cocaina, metanfetamina e dosi fuorimisura di Percodan o di benzodiazepine contro l’astinenza. Era strafatto già in pieno giorno, ridotto a uno schifo. Quando riuscì a vincere il terrore degli aghi sentì per la prima volta sparire i dolori dell’ulcera allo stomaco. Aveva consultato 15 medici e provato 60 tipi di farmaci per quel male che lo tormentava da quando era ragazzino. Ma per il male di essere che sentiva là in fondo, dove nessun medico poteva arrivare, anche l’eroina non bastava più. Così, scelse la morte.
Alle 6 del mattino Courtney lo trovò già in coma nella stanza 541 dell’Excelsior di Roma: bianco come un panno, con un rivolo di sangue che gli scendeva da una narice. Accanto i soccorritori trovarono 2 blister vuoti: c’erano 60 pillole di Roipnol dentro quel corpo che stavano trasportando d’urgenza al Policlinico Umberto I. In Italia i medici tentavano di riportarlo in vita con una lavanda gastrica. In America la CNN interrompeva le trasmissioni per annunciare la morte per overdose di Kurt Cobain.
«Vaffanculo. Toglimi questi tubi del cazzo dalla bocca». La più famosa rockstar degli anni ‘90 a un passo dalla morte aveva ritratto il piede: sembrava volesse ancora essere da questa parte del mondo. Già da piccolo dimostrava di volerci stare: era iperattivo, saltava da tutte le parti. Il pediatra gli tolse lo zucchero dalla dieta, ma niente: in casa non riuscivano a tenerlo fermo. Così, il medico decise di passare alla chimica: a 7 anni Cobain iniziò a familiarizzare con gli effetti del Ritalin. Ma se a quell’età gli davano un narcotico classificato come la cocaina, a chi si sarebbe affidato una volta diventato adulto?
Gli assegni delle royalty sui dischi venduti iniziavano ad arrivare e molti spacciatori se ne approfittavano. Spendeva anche 400 dollari di eroina al giorno, una quantità che avrebbe ucciso chiunque, non Cobain. A volte era Courtney che lo rianimava a un passo dalla morte con dosi di Valium e iniezioni di Narcan. Altre volte si rimetteva in sesto da solo perché c’era un concerto da portare sul palco. Quello negli studi di MTV a New York era allestito come se si dovesse celebrare un funerale. Gigli, candele nere, un lampadario di cristallo e una scaletta di 14 canzoni. 5 parlavano di morte, ma la chimica delle note composte dal vivo diede alla luce la migliore esibizione di Cobain di sempre.
Anche la sera al Saturday Night Live riuscì a ricomporre i pezzi che le dosi mandavano all’aria. Aveva deciso di bucarsi presto quel sabato per essere su di giri e affrontare la trasmissione. Carnagione terrea, capelli rossi, aveva appena vomitato fuori degli studi della NBC. Ma quando salì sul palco riuscì a venirne fuori con un’esibizione dal vivo delle sue, senza sbavature. «Cristo, quel ragazzo sa suonare», si lasciò scappare il direttore d’orchestra, G.E. Smith.
Quando il suo insegnante di chitarra Warren Mason gli chiese che canzoni volesse imparare a suonare, Kurt rispose Stairway to Heaven. Una scelta profetica vista la scalinata che avrebbe dovuto salire prima di raggiungere la pace da sempre desiderata. Aveva 17 anni quando fu messo alla porta dopo una lite ad alto volume: sua madre teneva relazioni approssimative con uomini che non gli andavano giù. 7 anni dopo scrisse Something in the way per trasmettere il senso di abbandono che sentì al grido: «Fuori di qui». Così, se era lui qualcosa che stava tra le scatole allora lui era quello che avrebbe dormito ovunque: in uno scatolone di cartone sotto il portichetto di un amico, negli atri riscaldati dei palazzi, nelle sale di aspetto del Grays Harbor Community Hospital. In quei 4 mesi senza un tetto solo le dita sulla chitarra gli rendevano la vita sopportabile. Si esercitava per ore ogni giorno e arrivava a suonare qualsiasi canzone dopo averla ascoltata solo una volta.
Realizzò che doveva proteggere quelle mani quando non suonava visto che ogni tanto lo chiamavano a mettere giù moquette nelle case. Poteva anche essere assunto per quel lavoro, ma la paura di tagliarsi prevalse. Eppure, fu proprio su quel furgone pieno di rotoli di tappezzeria che caricò gli strumenti per il suo primo concerto. Nessuno applaudì alla fine del primo pezzo, Downer, ma tutti in quella casa avevano appena ascoltato le prime note dei futuri Nirvana.
La band nel febbraio del 1989 era in viaggio verso la California per iniziare il tour quando Kurt vide la scritta «Bleach Your Works». Candeggia i tuoi attrezzi era un manifesto per la prevenzione contro l’Aids: aveva trovato il titolo per il loro primo album. In un ritaglio di giornale aveva trovato anche una storia terribile. Raccontava di una ragazza rapita, stuprata e torturata con una fiamma ossidrica. Kurt la riscrisse dal punto di vista dello stupratore. Fu così che Polly fece dire un giorno a Bob Dylan: «Quel ragazzo ha un cuore».
Il cuore della sua ragazza invece era tutto per lui. Tracy lo manteneva con il turno di notte che faceva in una tavola calda di Seattle. Anche Kurt ogni tanto cercava di portare a casa qualcosa. Per 4,75 dollari l’ora andò a lavorare alla Lemons Janitorial Service. Ma fare le pulizie negli uffici non gli lasciava le forze per i lavori che Tracy gli chiedeva: spazzare la cucina, scrollare i tappetini, passare l’aspirapolvere, pulire la lettiera del gatto. Per farsi perdonare un giorno compose una canzone così melodica che il pubblico dei concerti l’avrebbe scambiata per una cover dei Beatles. Scrisse About a Girl dopo avere ascoltato per 3 ore di fila l’album Meet the Beatles.
C’erano più di 1000 persone in fila davanti al Newbury Comics a Boston. Era il 24 settembre del 1991 e tutti aspettavano di entrare nel negozio di dischi per l’uscita del nuovo album. Nevermind ci mise 2 settimane ad arrivare nella Top 200 di Billboard. Entrò in posizione 144: dopo 4 settimane era già alla 35. Pochi gruppi erano riusciti ad arrampicarsi con quel ritmo, su quella classifica e senza la spinta da dietro del marketing. La DGC Records non se la aspettava: l’etichetta discografica aveva stampato solo 46.251 copie. Così, per molte settimane il disco rimase esaurito e la scalata si fermò. Quando ritornò nei negozi tolse la vetta a Dangerous di Michael Jackson grazie alle 373.520 copie vendute nella settimana dopo Natale. Erano soprattutto scambi di ragazzi che chiedevano Nevermind in cambio del disco ricevuto in regalo.
Quello che invece Kurt tentò ancora una volta di scambiare era la sua dipendenza con la disintossicazione. La stanza era la 206 al centro di recupero Exodus a Los Angeles: lo aspettavano 4 settimane di terapie di gruppo e incontri individuali. Al terzo giorno scavalcò il muro alto 2 metri della recinzione e se ne tornò a casa: c’era una lettera da scrivere. Aveva i suoi Levi’s preferiti addosso, le Converse da basket ai piedi: il televisore muto era sintonizzato sul canale MTV. Lo stereo diffondeva l’album Automatic for the people dei Rem. Durò 3 sigarette la stesura della lettera: quando la firmò, Michael Stipe era arrivato a Man on the moon.
Cobain invece arrivò nella stanza del guardaroba, spostò un asse dalla parete e dal cubicolo tirò fuori una custodia di nylon. Infilò 3 cartucce nel caricatore e tolse la sicura. In un sacchetto di plastica c’erano 100 dollari di black tar messicana: era un sacco di eroina. Ne staccò metà per scaldarla sul cucchiaio e spararsela in corpo. Poi, puntò la canna del fucile sotto il palato per l’ultimo sparo.
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2022 Mamy
