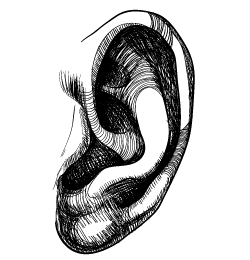
Troppo piccolo per diventare così grande.
«Sei sicuro di avere 8 anni?» Erano da poco passate le 5 del pomeriggio quando partirono dal parco Saavedra. Se si fossero sbrigati avrebbero fatto in tempo a tornare prima che diventasse buio: non era da persone responsabili entrare in quel barrio dopo il tramonto. Un rivolo di acqua sporca si faceva largo tra montagne di rifiuti. Lassù, i cirujas si arrampicavano tra le immondizie e le puzze dei fumi di fermentazione in cerca di qualche tesoro per poveri. A poca distanza si affacciava una piccola casa di mattoni dipinta in calce bianca. Una latrina in legno nel retro, davanti una porta in rete metallica: il filo spinato della recinzione la separava dalla strada. «È qui» disse Diego.
Il padre l’aveva messa in piedi con le sue mani: qualche lamiera di recupero, un po’ di mattoni sfusi, il resto erano imballaggi di cartone riciclati. Le stanze sembravano scatoloni separate da porte fatte con sacchi di iuta. Sotto i piedi il pavimento era di cemento levigato. Al centro della cucina due vecchie sedie facevano compagnia a un tavolo nudo. La credenza e il fornello avevano tutta l’aria di volere fare altrettanto, come del resto le altre due stanze. Una era la camera da letto di 2 adulti, l’altra quella di 7 bambini.
Se un racconto corrisponde a verità, il protagonista della storia prima o poi arriva all’orecchio di qualcuno che sa cosa farne. All’autotrasportatore José Trotta nel dicembre del 1968 gliene raccontarono una che non poteva passare inosservata. Nella baraccopoli di Villa Fiorito, dentro il Nono Quartiere del distretto di Lomas de Zamora, viveva un ragazzino che con la palla al piede sapeva raccontare storie mai viste prima.
Prima di quel giorno nessuno a Buenos Aires aveva visto fare da un bambino così piccolo cose così grandi. Nemmeno l’allenatore dei Cebollitas, la squadra giovanile dell’Argentinos Juniors dove Trotta portò quel narratore in erba, di nome e di fatto. Eppure, Francisco Cornejo ne aveva visti di ragazzini giocare a pallone: era il suo mestiere. Ma di fronte alla naturalezza delle giocate di Diego non credeva ai propri occhi, e nemmeno alla sua età. «Ospedale Eva Perón di Lanús, 30 ottobre 1960». Lesse quei numeri e quelle parole su un foglio di carta la sera stessa che lui e Trotta lo riaccompagnarono a casa. Donna Tota recuperò il documento dalla sua stanza per soddisfare lo spirito indagatore di quell’uomo. Ma una madre non poteva mentire sulla data di nascita del figlio, nonostante ci fosse quell’atto di nascita a garanzia delle sue parole.
Per l’età che aveva era troppo magro e basso di statura: c‘era il rischio che uscisse sempre conciato male al termine di ogni partita se il suo fisico non avesse acquistato peso, altezza e struttura. La sua carriera poteva essere compromessa. A prefigurarne il pericolo fu Roberto Paladino, un medico dall’ambigua reputazione che gli diagnosticò un principio di rachitismo. E a ogni dannata prefigurazione arriva sempre in soccorso una prescrizione.
«Ecco deve dargli queste. Non sono medicine, sono vitamine». Donna Tota guardò la confezione come se l’avessero accusata di non dare da mangiare a suo figlio. In quello sguardo c’era tutto l’orgoglio della povertà che fa sacrifici con i pochi pesos guadagnati dal marito in fabbrica e da lei che li portava a casa dopo avere stirato il bucato dei vicini. Le vitamine non costavano poco eppure a Diego non sarebbero mai mancate. In 6 anni di cura il medico gli prescrisse più di 100 ricette di vitamine che quando finivano il padre andava ad acquistare. Senza quell’opera ricostituente della chimica, la natura non avrebbe modellato il suo fisico per resistere a tutti gli urti e colpi che gli avversari gli avrebbero assestato.
Nel frattempo, lo tenevano a bordo campo a fare il raccattapalle durante gli incontri di Primera División dell’Argentinos. Poteva essere solo qualcuno che lo conosceva il tizio che gli tirò un pallone durante l’intervallo di una partita contro il Boca Juniors. Collo del piede, coscia, tacco, testa, spalla, schiena, e poi collo del piede, coscia, tacco, testa, spalla, schiena, e ancora collo del piede, coscia, tacco, testa, spalla, schiena: era il suo numero da circo che lasciava presagire le gesta di un numero 10. Qua e là si alzarono alcuni applausi dagli spalti dello stadio Vélez Sarsfield: in pochi secondi diventarono il frastuono di tutta una curva. La gente iniziava a conoscere Diego Armando Maradona. Se ne accorse pure il giornalista del Clarín che il giorno dopo scrisse un pezzo sul quotidiano. Raccontava di uno sconosciuto ragazzino di nome Diego Caradona, tanto era sconosciuto.
Ma a conoscerlo per primo fu un produttore televisivo che cercava bambini fenomenali per il suo programma di fenomeni. Così, molto prima che in campo Diego Maradona finì a palleggiare con un’arancia e una bottiglietta in una trasmissione. Proprio lui che aveva preso a calci il pallone più bello del mondo fino a pochi istanti prima di venire al mondo. Quello vero imparò a calciarlo mentre iniziava a stare in equilibrio su quei due piedi, uno più extraterrestre dell’altro. Fu lo zio Cirilo a regalarglielo per il suo terzo compleanno. Da quei primi passi sarebbero nati i suoi primi numeri con quel giocattolo che rotolava sul piazzale sterrato di Villa Fiorito, volava in aria, atterrava sulla sua testa e si insaccava nella porta di casa.
Lì, gli applausi poteva solo immaginarli, ma mai avrebbe pensato di sentire il loro contrario in una partita. A preoccupare era il fatto che gli insulti arrivavano proprio dagli adulti, dirigenti e genitori delle squadre avversarie. Ma contro i mezzucci che bocche poco istruite potevano lanciare dagli spalti arrivava lui con i suoi mezzi tecnici a zittirli tutti in campo. A quell’età era raro vedere un ragazzino marcare a uomo un altro ragazzino: lo scopo di una squadra era creare il proprio gioco, non annullare quello degli avversari. Con Diego tutto sarebbe cambiato. Un difensore lo pedinava per tutto il campo e per tutto il tempo. Se non riusciva a stargli dietro lo atterrava, a volte con le buone, molto spesso con le cattive. «Ricordati che picchiano solo i migliori».
Al decimo del secondo tempo 6 tacchetti si piantarono all’altezza del ginocchio destro: era la gamba di appoggio, visto che con il sinistro stava facendo una delle sue magie. La smorfia di dolore, il pianto, le mani sul viso: non ci volle molto per capire che era qualcosa di serio. Alla sera Diego aveva 40 di febbre, la gamba gonfia e il ginocchio tutto nero. Fu il dottor Bortman il giorno dopo a estrarre quel versamento di liquido scuro con una siringa e un ago enorme. All’ospedale Israelita gli ingessarono la gamba dalla coscia alla caviglia. Furono gli unici 18 giorni della sua vita senza calcio, prima che il calcio diventasse il suo mestiere.
Come ragazzino della baraccopoli più pericolosa di Buenos Aires Maradona iniziò a guadagnarsi da vivere con ogni espediente. Nelle stazioni più affollate della capitale racimolava qualche peso argentino aprendo le porte del taxi a chi stava per prenderlo, vendeva i ferri vecchi che trovava lungo la strada o barattava la carta stagnola dei pacchetti di sigarette vuoti lasciati sui marciapiedi.
Per uno che da adulto avrebbe sempre dichiarato in pubblico di non vergognarsi da dove veniva, ricevere a 15 anni le chiavi di un appartamento non era solo il segnale di quanto il club credeva in lui. Era il segno – più fatato che fatale – che gli stracci indossati si possono davvero ricucire con un tocco da favola in un abito da sera, che le zucche si possono trasformare in carrozze fuoriclasse. E che 165 centimetri di un narratore in erba possono diventare sul campo i più grandi di tutti.
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2021 Mamy
