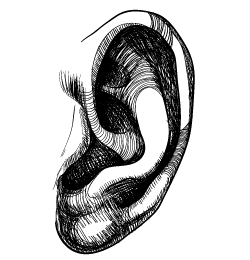
La testa dentro
la racchetta di
Andre Agassi.
Raparsi a zero è come azzerare la propria carriera e ricominciare dopo che sei stato numero uno e poi sei finito al centoquarantunesimo posto. Fuori dalla squadra di Davis, fuori dai tornei che contano, fuori dalle teste di serie: non puoi avere nemmeno un diavolo per capello. Le vittorie ti posizionano in classifica e la classifica negli sponsor, nei media, nei tifosi, nel morale. Se vieni giù dal trono precipiti e viene giù anche lo spirito: il suo non è santo, ma sacro per un tennista che guadagna con il suo gioco grazie a quello che gli accade nella testa.
Se scendi dalla vetta non puoi galleggiare in mezzo alla classifica. Devi andare ancora più giù, fino in fondo. Tornare agli inizi. Uscire dalle scorie delle sconfitte nell’Atp e farti una bella lavanda tennistica nei challenger, il campo base più basso nella scalata del tennis professionistico. Il primo torneo è a Las Vegas. Per il vincitore è pronto un assegno di 3500 dollari: spiccioli sparsi ai piedi dei montepremi degli Slam. I campi sono gli stessi di quando aveva 7 anni. Ora ne ha 20 in più. Il pasto prima della partita è uguale a quello consumato a bordo dell’aereo che lo ha portato lì per giocarla. Ci sono solo 3 palle a disposizione per farlo e solo un ragazzino che le raccatta tra un punto e l’altro. Attorno, niente spalti gremiti, ma altri campi dove altri giocatori cercano di rubarsi il passaggio del turno. Dalle reazioni ai colpi si intuisce come sta andando il loro punteggio. Per aggiornare quello della sua partita deve cambiare i numeri nel tabellone con le mani.
Alla caduta dei capelli aveva fatto salire sulla testa un parrucchino. Quelli ancora attaccati sotto la nuca li aveva fatti crescere e striati come la coda di un cavallo in tre tinte. Alla caduta dalla cima della classifica invece aveva fatto salire alla sua attenzione solo sé stesso. La forza di gravità si era presa tutti i possibili successi futuri: di fronte al tennis non si era mai sentito così nudo, soprattutto nella testa. Dentro c’era solo quello che doveva mettere in campo.
Borbottano, sussurrano, bisbigliano. Negli altri sport non si prendono a pallate con le parole. Nel tennis invece fai tutto da solo: ti urli addosso e ti rispondi con lo stesso tono. Al cambio di campo nessuno si siede al tuo fianco tra un gioco e l’altro. Ti multano se ti scoprono a lanciare messaggi al tuo team nascosto tra gli spettatori. Per uscire da quella solitudine inizia a giocare a calcio: lì, la sconfitta può condividerla con i compagni. «Non ci giocherai più. Tu sei un tennista. Diventerai il numero uno. Il programma è questo. Punto e basta».
Il programma è 2500 palle al giorno, 17.500 colpi a settimana, quasi 1 milione in un anno. Per uno sport fatto di dritti e rovesci in rapida successione, di angoli da mirare con il goniometro e di linee da tracciare con un passante, la matematica e la geometria sono materie da studiare sul campo da tennis, non sui banchi di scuola. I numeri non mentono. Un bambino che colpisce un milione di palline in un anno ha un milione di probabilità di diventare un ragazzo imbattibile dopo 10 anni. Per questo, a 3 anni qualcuno in famiglia gli mette in mano una racchetta con il manico segato e lo autorizza a colpire tutto quello che vuole.
Lui alla sera si sdraia sul letto, ma sul soffitto vede un campo da tennis di giorno e sogna partite intere di notte. «Prendi la racchetta! C’è qualcuno da battere» lo sveglia al mattino la voce di suo padre. Ha 9 anni, ma non come tutti i bambini che si alzano per andare a scuola. Lui è già in piedi pronto per giocare la partita, dopo avere colpito palline per tutta la mattina. Ne colpisce così tante che dopo mezz’ora il cemento verde del campo diventa un tessuto sintetico giallo. Emanoul Aghasi le raduna con il soffiatore che aveva acquistato per asciugare il campo: in Nevada non piove mai. Poi con una pala riempie i bidoni di metallo che a turno alimentano la bocca del lanciapalle.
«Colpisci prima. Colpisci prima». Colpire quello che la macchina gli tira addosso, a destra o a sinistra non gli basta. Vuole che suo figlio colpisca più svelto della macchina. Vuole che diventi una macchina. Si dispiace se è larga, fa un gesto di stizza non appena la tira lunga, ma non si trattiene quando finisce in rete. «È lei il tuo primo avversario, dannazione» gli grida mentre conta le palline assembrate a ridosso della metà campo. Gli errori di misura sono una cosa, la rete è un’altra. Così, la alza di 15 centimetri rispetto alla misura regolamentare. Per migliorare i propri colpi ci vuole un’opposizione del nemico più alta.
Ci vogliono invece almeno 21 set per vincere un torneo Slam. 45 se le 7 partite che devi giocare per alzare il trofeo le porti tutte al quinto. Ma, bene o male che ti vada, è sempre un conto alla rovescia: devi azzerare quel numero, partita dopo partita. Devi alleggerirti dal peso di essere ogni volta perfetto sopra la rete e fare sentire addosso all’avversario la pesantezza dei tuoi colpi nella sua metà campo.
«Tira qualche rovescio. Prova qualche servizio. Adesso vieni a rete». Dopo mezz’ora è già al telefono con il padre. Non ha mai visto un ragazzino con un talento così. «Voglio portarlo in alto. Voglio farlo a mie spese». Per Andre cambia il torturatore, non la tortura. Sveglia alle 6 e mezza del mattino. 30 minuti di colazione. 4 ore di scuola. 30 minuti per pranzare. Un intero pomeriggio per allenarsi. Tutti i santi giorni all’Academy di Nick Bollettieri per diventare Andre Agassi.
Imparerà a mettere sempre nella racchetta il suo colpo più forte. 14 anni dopo capirà che non serve cercare il punto con i propri punti forti, ma trovarlo nei punti deboli dell’avversario. Imparerà a essere il migliore al mondo ogni volta che scende in campo. 14 anni dopo giocherà per essere soltanto migliore di chi sta al di là della rete. Per tenere in vita il gioco invece di cercare di farlo morire subito con un colpo vincente. Cercarlo in ogni palla giocata è giocare contro sé stessi. È questa la differenza tra giocare con il talento e giocare con la testa. Che se la testa è tutto quello che metti nei colpi, anche se il talento non l’hai portato del tutto in campo, alla fine ne uscirai vincitore. Almeno di fronte a te stesso.
22 anni. È il tempo necessario per nascere, crescere a fianco di un padre, formarsi all’Academy di uno scopritore di talenti, vincere il primo Slam e scoprire di avere talento. Ne bastano 2 per perderlo. È il 1997. Il secondo challenger è in un parco pubblico a Burbank, una contea di Los Angeles. A destra del campo centrale un albero disegna un’ombra lunga 6 metri. Si sentono i bambini giocare a pallone poco lontano, le auto correre sulla strada a più corsie, la musica intrattenere i clienti di un bar. È lì che si rifugia dopo avere perso la partita al terzo turno. A Göteborg, Michael Chang e Pete Sampras difendono gli Usa contro la Svezia in Coppa Davis. Lui si ripara sotto l’albero del parco dopo il pasto. Se non riesci ad accettare che sei dove devi essere, non potrai mai tornare là dove vuoi tornare.
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2022 Mamy
