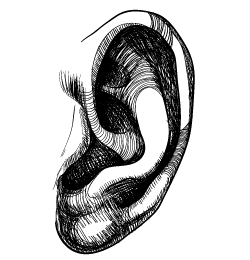
Starbucks, l'immobiliare del caffè.
«Le code indicano che ci servono più negozi». Se la gente in fila sbuffava più di 3 minuti in attesa di ordinare, per Jim Donald significava che quel punto vendita non era abbastanza comodo. Lui era l’amministratore delegato e quello era il punto di non ritorno nel piano di espansione dell’azienda. Ogni volta che veniva raggiunto, Donald autorizzava l’apertura di una nuova caffetteria, il più vicino possibile a quella della coda.
Herb Hyman ne aveva già una vicino alla sua poco dopo avere rifiutato la loro offerta. Ci aveva messo 30 anni a costruirla e ora arrivavano loro a Los Angeles a chiedergli di venderla: «Altrimenti circonderemo i tuoi negozi con i nostri». Così, chiamò l’amico Jim Stewart della società Seattle’s Best Coffee per sapere che cosa accadeva quando Starbucks apriva un proprio negozio vicino al tuo. «Finirai per amarlo. Faranno marketing anche per te e le tue vendite aumenteranno».
Ma fare marketing per Starbucks non voleva dire occuparsi di caffè: quello era solo la porta di ingresso. Erano invece gli immobili l’oggetto preso di mira dal piano. Un database classificava ogni area metropolitana in base a reddito, densità e istruzione degli abitanti. Al centro del quartiere più ricco e pieno di vitalità mettevano in piedi il negozio di rappresentanza. Poi, attorno a quel perno ogni anno costruivano 10 negozi da battaglia nel raggio di un isolato: era la fortezza attorno al proprio territorio. Faceva economia di scala tra le truppe al fronte e costringeva il nemico tra le pattuglie della concorrenza a costruire il proprio perno nell’area di fascia inferiore.
Alla fine, era come una campagna militare: tra perno e raggio si consumava l’occupazione dell’area migliore come flusso di persone per poi passare alla successiva. Il rischio della saturazione era la cannibalizzazione, ma Starbucks sul quel punto cruciale per la vendita non ammetteva obiezioni: preferiva perdere ingressi dei clienti invece di fare spazio all’ingresso di un concorrente. Chi usciva dagli uffici di un quartiere a Manhattan poteva scegliere tra 12 diversi Starbucks nel raggio di 3 isolati, quasi sempre a fianco di negozi di video e lavanderie. Lì dentro i passaggi dei clienti raddoppiavano – uno per il ritiro, l’altro per la consegna – e così era probabile raddoppiassero anche gli ingressi nella caffetteria vicina.
Quando nel 1994 Howard Schultz lanciò il grido di battaglia «2000 entro il 2000» erano 400 le caffetterie aperte da Starbucks, ma nessuno sembrava credere a quelle parole e nemmeno gli investitori finanziari a quei numeri. Avrebbe dovuto moltiplicarli per 5 in soli 5 anni, mentre ad accompagnarli c’erano i costi di realizzazione che si moltiplicavano su ogni punto vendita: da 200 erano passati a 350 mila dollari. Per dimostrare a Schultz che era destinato a fallire mandò alcuni dipendenti nel negozio Home Depot ad acquistare tutte le componenti necessarie per mettere in piedi una caffetteria Starbucks.
Wright Massey disegnava Disney Store per i centri commerciali, quando Schultz lo assunse per affidargli la missione: ridurre i costi e mantenere nello stesso tempo i negozi diversi tra loro. «Mi diedero 1 milione e mezzo di verdoni e in 1 anno realizzai la customizzazione di massa». Gli diedero anche un loft a sud di Seattle dove isolò il suo staff dal resto dei dipendenti dell’azienda. In quello spazio tutto suo si circondò di grafici, decoratori di interni, architetti e anche di poeti: se i negozi di Starbucks dovevano offrire emozioni, allora c’era bisogno anche di chi le emozioni le sapeva creare. Eppure, questo non sarebbe bastato. Ci voleva qualcuno con alle spalle l’esperienza necessaria per capire quali emozioni la gente desiderava vivere in una caffetteria come Starbucks.
Jerome Conlon aveva passato la vita a esplorare la mente del consumatore. Un tempo lo aveva fatto per la Nike, ora era stato chiamato a farlo per Starbucks. Il suo compito era scoprire che cosa le persone cercassero nelle caffetterie d’America. Chiamò l’indagine il Grande Scavo: 9 mesi a studiare la metafisica del caffè. Dagli scritti dei frequentatori delle caffetterie del Settecento a Londra fino alle interviste a 100 bevitori di caffè nel 1996.
A loro Conlon chiese di chiudere gli occhi e di descrivere come sarebbe stato il caffè dei loro sogni attraverso i 5 sensi. Alla fine, sembrava che tutti avessero fatto lo stesso sogno: tutti gli parlarono dello stesso luogo. Nessuno parlava di aroma, profumo o acidità, tutti parlavano di relax, calore, lusso: la caffetteria come un salotto pubblico. La gente voleva l’esperienza del caffè sul luogo, non nella tazza. E per viverla era disposta a pagare, anche molto. Lo sapeva bene Howard Schultz che per una di quelle tazze riusciva a farsi dare 1 dollaro e 60 centesimi, quando tutti gli altri brand si portavano a casa solo 50 centesimi.
La tazza era solo il prezzo di ammissione per prendere parte alla socialità a distanza che si componeva ogni giorno nella caffetteria. Il caffè era il media, il posto il social. La questione non era l’aroma del caffè, ma l’atmosfera del posto. Lì, la gente ci va per stare da sola, ma per farlo ha bisogno di sentire attorno a sé un po’ di compagnia. Dopo la casa e l’ufficio gli americani avevano bisogno di qualcosa che li facesse entrare in un Terzo Luogo. Schultz scelse di non darlo in concessione a terzi con il franchising: per questo non temeva di aprire una sua caffetteria di fronte a un’altra sua caffetteria. Di ognuna controllava ogni dettaglio: i colori sulle pareti, i caratteri sulle confezioni, le parole nelle pubblicazioni. Metteva la sua firma su ogni cosa: niente usciva senza la sua approvazione. Il suo dipartimento immobiliare studiava ogni possibile collocazione per creare quella densità di caffetterie che – come un puzzle – avrebbe composto l’immagine aziendale di Starbucks.
«Non ci siamo mai dedicati alla costruzione del brand». I 10 milioni di dollari che Coca Cola avrebbe speso in 2 giorni, Starbucks li aveva investiti in 10 anni. Perché era nella costruzione del prodotto che Schultz costruiva il brand, e il prodotto non era il caffè. Se ne accorse anche Interbrand la società di consulting che nel 2004 nominò Starbucks il quarto brand più importante al mondo dopo Apple, Google e Ikea. Eppure, agli occhi dei suoi clienti Starbucks poteva apparire il contrario di quello che in realtà era: non una catena di negozi di caffè, ma un gruppo immobiliare specializzato in assembramenti di caffetterie. Questo è il marketing: quello che c’è sotto la superficialità, dopo lo scavo. Il vero marketing è quello che non si vede.
Lui invece ci avrebbe visto molto bene un giorno del 1981 quando notò qualcosa di strano nel bilancio della Hammerplast. Howard Schultz aveva solo 28 anni e di quella azienda svedese di prodotti casalinghi era già il vicepresidente. Tra le tante cifre che stava scorrendo furono quelle di una piccola azienda di Seattle a fermare il suo sguardo. La Starbucks Coffee, Tea and Spices ordinava più caffettiere a filtro rispetto a quelle che ordinava il grande magazzino Macy’s. Non poteva sorvolare su quella anomala differenza contabile. Mise due-tre cose in valigia e salì sul primo volo disponibile per andare a scoprire le ragioni di acquisto di tutte quelle caffettiere, anche se lui di caffè non ne capiva un chicco.
Eppure, tra tutti quei chicchi Schultz fiutò il profumo degli affari. Quando entrò nello Starbucks di Pike Place Market gli bastò una boccata per sentire aria di business. Poi 1 anno per farsi assumere come responsabile marketing, 5 anni per rilevare l’azienda dal proprietario Jerry Baldwin, 6 anni per portare le caffetterie da 425 a 3500. Il piano di finanziamento era di fortuna, ma fu il piano di espansione immobiliare a fare la sua fortuna. Nel 1995 erano cresciute di 250, di 340 l’anno successivo, di 400 nel 1997, di 470 nel 1998 e di altre 600 l’anno dopo. All’inizio, la coda di clienti aveva indicato a Jim Donald che servivano più caffetterie. Alla fine, la coda di numeri della loro crescita indicava a Starbucks che stava servendo un sacco di clienti.
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2021 Mamy
